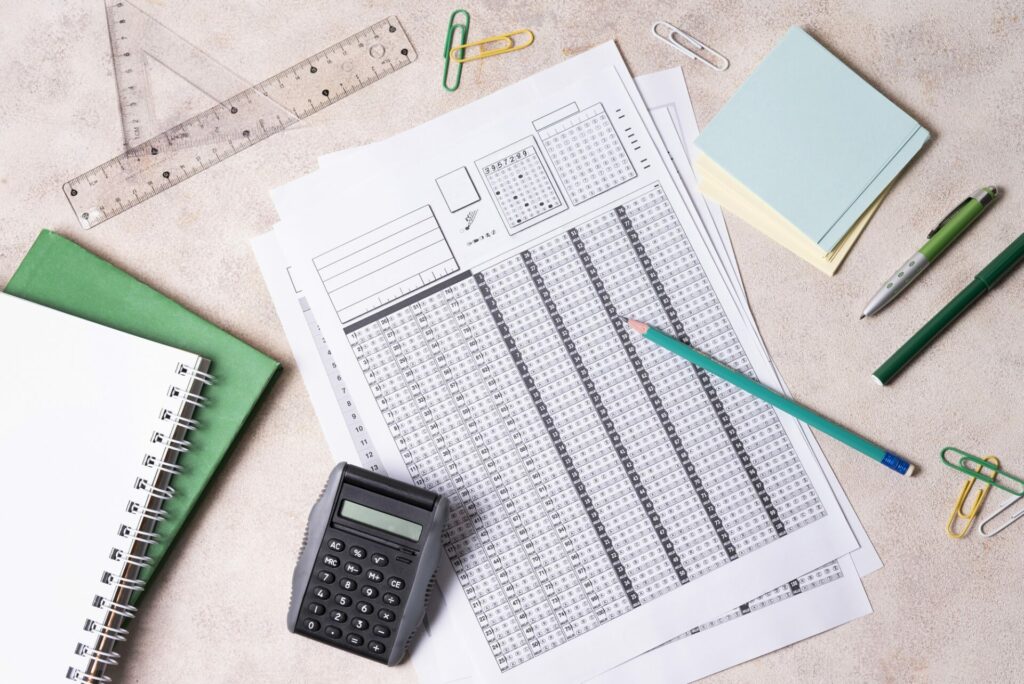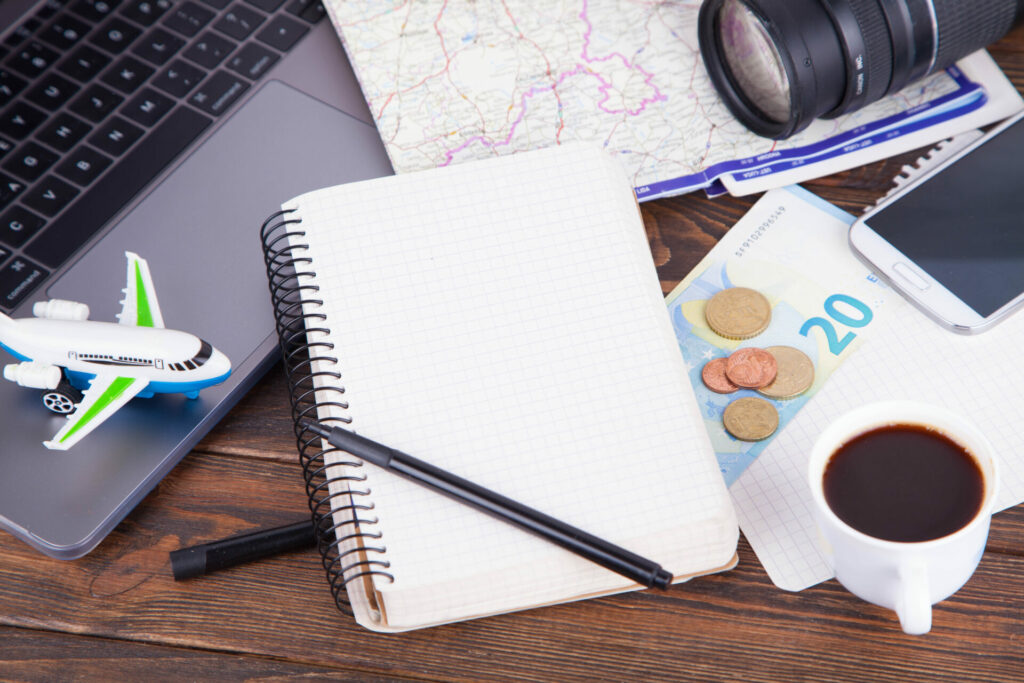Con l’arrivo della scadenza del 30 aprile 2025, imprese e professionisti sono chiamati a presentare la Dichiarazione IVA 2025 relativa all’anno d’imposta 2024. Una scadenza fondamentale che comporta non solo adempimenti formali ma anche conseguenze fiscali importanti in caso di ritardi o errori.
Sommario
In questo articolo analizziamo tutte le regole da seguire, le novità introdotte, e soprattutto come evitare sanzioni e ottimizzare la gestione dell’IVA.
L’obiettivo è aiutare il contribuente, o chi lo assiste, a risparmiare tempo e denaro, gestendo in maniera efficiente e consapevole un adempimento che non è mai solo burocratico, ma anche strategico.
Chi deve presentare la Dichiarazione IVA 2025
La Dichiarazione IVA deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d’imposta che, nel corso del 2024, hanno esercitato attività rilevanti ai fini IVA. Parliamo quindi di imprese individuali, società, liberi professionisti, enti non commerciali che svolgono attività commerciale in modo occasionale o continuativo. Non rileva il regime contabile adottato: anche chi è in regime forfettario o dei minimi potrebbe essere tenuto alla dichiarazione in casi specifici.
Sono invece esonerati dalla presentazione:
-
I contribuenti che hanno realizzato solo operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72) e non hanno detratto l’IVA;
-
I soggetti che si sono avvalsi del regime forfettario o di vantaggio, salvo che abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o con l’estero;
-
I contribuenti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale o identificati direttamente.
È fondamentale capire se si rientra tra gli obbligati, anche solo per evitare omissioni che possono costare caro, con sanzioni che partono da 250 euro fino a 2.000 euro in caso di mancata dichiarazione.
Scadenze ufficiali e modalità di presentazione
Il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno d’imposta 2024, è fissato al 30 aprile 2025. A stabilirlo è il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 9491 del 15 gennaio 2025, con cui sono stati pubblicati il Modello IVA/2025 e le relative istruzioni ufficiali per l’adempimento, in conformità con l’articolo 8 del D.P.R. 322/1998, aggiornato dalle successive modifiche normative.
Inoltre, con un successivo Provvedimento n. 21479 del 28 gennaio 2025, sono state rese note anche le specifiche tecniche necessarie per la corretta trasmissione telematica della dichiarazione, sottolineando così l’obbligo di presentazione esclusivamente in via digitale.
La trasmissione può avvenire secondo quattro modalità:
-
Direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline);
-
Tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o consulente fiscale;
-
Per il tramite di soggetti incaricati, nel caso di Amministrazioni dello Stato;
-
Tramite società del gruppo, nei casi previsti dall’art. 3, comma 2-bis, del DPR 322/1998.
La dichiarazione si considera presentata regolarmente solo nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate conferma la ricezione dei dati. A tal fine, viene rilasciata una ricevuta telematica che costituisce prova legale dell’avvenuta trasmissione.
Modelli IVA/2025 e IVA BASE
Con il Provvedimento n. 9491/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la pubblicazione dei modelli IVA/2025 e IVA BASE/2025, entrambi riferiti al periodo d’imposta 2024. La scelta tra uno e l’altro dipende dalla tipologia di contribuente e dalla complessità delle operazioni IVA effettuate durante l’anno fiscale. È quindi importante conoscere la struttura e i quadri inclusi per capire quale modello compilare.
Il Modello IVA/2025 ordinario è composto da:
-
Il frontespizio, che comprende anche l’informativa sul trattamento dei dati personali;
-
I quadri: VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ, necessari per la dichiarazione completa di tutte le operazioni attive e passive, liquidazioni, rimborsi e versamenti.
Il Modello IVA BASE/2025, invece, è pensato per i contribuenti che hanno situazioni più semplici da dichiarare. Include:
-
Il frontespizio;
-
I quadri: VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
È fondamentale scegliere il modello corretto, perché la compilazione errata può generare scarti nella trasmissione o errori formali con conseguenze anche in termini sanzionatori. Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che eventuali aggiornamenti dei modelli o delle istruzioni saranno sempre pubblicati nella sezione dedicata del sito ufficiale, con apposita comunicazione.
Un controllo preventivo dei quadri da compilare in base alle operazioni svolte nel 2024 è il primo passo per una dichiarazione IVA corretta e senza intoppi.
Soggetti obbligati ed esonerati
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA che, nel corso del 2024, hanno esercitato attività d’impresa, arti o professioni, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPR 633/1972.
Tuttavia, esistono casistiche particolari in cui l’obbligo si estende a soggetti specifici, come ad esempio:
-
Curatori fallimentari,
-
Eredi del contribuente deceduto,
-
Società incorporanti o beneficiarie in caso di fusione o scissione.
Sul fronte opposto, sono esonerati dalla dichiarazione IVA 2025 i contribuenti che rientrano in determinate situazioni agevolate o semplificate.
Tra questi:
-
Chi ha effettuato solo operazioni esenti (art. 10), senza obbligo di fatturazione e registrazione (art. 36-bis);
-
I soggetti in regime forfettario (Legge 190/2014, commi 54-89) o nel regime dei minimi (DL 98/2011, art. 27);
-
Produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6);
-
Chi organizza giochi e intrattenimenti (art. 74, comma 6) e non ha optato per il regime IVA ordinario;
-
Le imprese individuali che abbiano concesso in affitto l’unica azienda;
-
I soggetti passivi con sole operazioni non imponibili o esenti, prive di obbligo di versamento dell’imposta;
-
Le associazioni sportive dilettantistiche e culturali che adottano il regime 398/1991;
-
I soggetti non residenti identificati in Italia tramite art. 74-quinquies;
-
I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi o piante officinali, con volume d’affari sotto i 7.000 euro;
-
Le organizzazioni di volontariato e APS che hanno optato per il regime speciale agevolato.
È essenziale verificare con precisione la propria posizione fiscale: l’invio non dovuto può essere evitato, ma l’omissione da parte di soggetti obbligati comporta sanzioni rilevanti.

Le novità sul credito IVA e codice attività
Un contributo prezioso all’interpretazione delle novità di quest’anno arriva dalla Circolare n. 6 pubblicata da Assonime il 25 marzo 2025, che analizza approfonditamente i principali cambiamenti introdotti nel modello IVA/2025, soffermandosi in particolare sulla gestione dell’eccedenza di credito IVA e sulla nuova classificazione ATECO.
In materia di credito IVA, viene chiarito che l’eccedenza d’imposta detraibile indicata nel rigo VX2, eventualmente sommata all’importo presente nel rigo VX3 (relativo ai versamenti), deve essere ripartita nei righi VX4, VX5 e VX6.
Questi righi servono per indicare la destinazione del credito secondo quattro opzioni:
-
Riporto in detrazione nell’anno successivo;
-
Compensazione orizzontale con altri tributi e contributi;
-
Richiesta di rimborso (interamente o in parte);
-
Cessione al consolidato fiscale, per i soggetti aderenti al regime.
Assonime richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta indicazione di questi dati, in quanto una scelta errata può compromettere l’accesso al rimborso o generare sanzioni per indebita compensazione.
Inoltre, la circolare affronta le nuove indicazioni sul codice attività da riportare nel rigo VA2, in relazione all’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025. Sarà quindi obbligatorio aggiornare i codici attività, adeguandoli alla nuova codifica, pena lo scarto della dichiarazione o la sua inammissibilità.
Una novità tecnica che richiede attenzione e aggiornamento tempestivo per evitare errori nella compilazione.
Come gestire correttamente il credito IVA 2024
Uno degli aspetti più importanti della Dichiarazione IVA 2025 è la corretta gestione dell’eventuale credito IVA maturato nel 2024. Si tratta di un elemento che non solo impatta sulla liquidità aziendale, ma che può anche offrire vantaggi fiscali significativi, se gestito in modo attento e strategico.
Come visto, nel quadro VX del modello si deve indicare come si intende utilizzare l’eccedenza di imposta: lasciarla a credito per l’anno successivo, usarla in compensazione orizzontale con altri tributi (es. INPS, IMU, IRES, IRAP), richiederla a rimborso oppure cederla al consolidato fiscale. Ma qual è la scelta migliore?
- La compensazione orizzontale può essere particolarmente utile per le imprese che devono sostenere alti costi contributivi o tributi locali. In questo modo si evita l’esborso di cassa e si migliora la gestione finanziaria interna.
- Il rimborso, invece, è da preferire in caso di crediti elevati e strutturali, come accade nei settori export o per chi sostiene ingenti acquisti di beni strumentali.
Attenzione: per accedere al rimborso è spesso necessaria la presentazione del visto di conformità o della garanzia fideiussoria, oltre al rispetto di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. Errori formali o mancanza dei requisiti possono bloccare il rimborso o causare contestazioni.
Una corretta pianificazione fiscale – anche con l’aiuto del proprio commercialista – consente non solo di evitare sanzioni, ma anche di trasformare il credito IVA in un’opportunità di risparmio legale e immediato.

Gli errori più comuni nella Dichiarazione IVA
Compilare correttamente la Dichiarazione IVA 2025 è un passaggio fondamentale non solo per adempiere agli obblighi fiscali, ma anche per evitare sanzioni che possono essere molto pesanti. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sempre più stringenti, anche grazie all’incrocio automatico dei dati tra fatture elettroniche, registri IVA e dichiarazioni annuali.
Ecco gli errori più frequenti che i contribuenti (e talvolta anche i professionisti) commettono:
-
Indicazione errata dei codici attività: con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 (operativa dal 1° aprile), un codice non aggiornato può generare lo scarto della dichiarazione.
-
Mancata o errata compilazione dei quadri VX: in particolare, una gestione scorretta del credito IVA (es. richiesta di rimborso non spettante) può attivare accertamenti e sanzioni.
-
Omissione di operazioni intracomunitarie: spesso sottovalutate, ma devono essere correttamente registrate anche se esenti da IVA.
-
Dimenticanza di rettifiche IVA (art. 19-bis2): nei casi di variazioni o cessazione attività, queste devono essere obbligatoriamente riportate.
-
Utilizzo di un modello sbagliato: ad esempio l’uso del Modello IVA BASE in situazioni che richiedono l’ordinario può causare problemi in fase di trasmissione.
-
Mancanza del visto di conformità, ove richiesto, per rimborsi superiori a 5.000 euro.
Le sanzioni per errori formali o dichiarazioni omesse possono variare da 250 a 2.000 euro, ma se vi è indebita detrazione o compensazione di crediti, si può arrivare a sanzioni pari al 30% del credito utilizzato.
Prevenire questi errori significa non solo evitare sanzioni, ma anche garantire una gestione fiscale corretta e trasparente.
Cosa fare in caso di errori
Anche con la massima attenzione, può capitare di commettere errori o dimenticanze nella compilazione della Dichiarazione IVA 2025. Fortunatamente, l’ordinamento fiscale italiano offre la possibilità di correggere spontaneamente le irregolarità tramite il cosiddetto ravvedimento operoso, evitando le conseguenze più gravi in termini di sanzioni.
In caso di:
-
Dichiarazione già inviata ma con errori formali (es. dati anagrafici, codici tributo, importi errati),
-
Omissione di righi obbligatori o quadri (come il VX o il VE),
-
Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2025,
è possibile inviare una dichiarazione integrativa nei termini previsti.
Ecco le soluzioni disponibili:
-
Dichiarazione correttiva nei termini: se l’errore viene rilevato prima della scadenza (30 aprile 2025), si può semplicemente inviare una nuova dichiarazione che sostituisce la precedente.
-
Dichiarazione integrativa: si può trasmettere una versione corretta della dichiarazione anche dopo la scadenza, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo (quindi fino al 2030 per la dichiarazione 2025).
-
Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare violazioni (errori, omesse dichiarazioni, crediti indebitamente usati) versando sanzioni ridotte proporzionali al tempo trascorso dalla violazione (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Ad esempio, per una dichiarazione omessa presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, ovvero 25 euro, se regolarizzata entro il termine e accompagnata dal pagamento delle imposte eventualmente dovute.
Un’azione tempestiva permette di evitare accertamenti e contenziosi, tutelando l’impresa anche sotto il profilo reputazionale e finanziario.
Considerazioni finali
La Dichiarazione IVA 2025 non è solo un adempimento obbligatorio da rispettare entro la scadenza del 30 aprile 2025, ma rappresenta anche un momento strategico per fare il punto sull’andamento fiscale e amministrativo dell’attività. Gestire in modo corretto e consapevole l’IVA consente di prevenire problemi, evitare sanzioni e sfruttare vantaggi legali, come la compensazione dei crediti o la richiesta di rimborsi.
Ogni quadro del modello IVA racconta un pezzo dell’attività del contribuente. Dalla determinazione dell’imposta dovuta o a credito, all’utilizzo strategico delle eccedenze, fino alla comunicazione puntuale dei codici attività e delle operazioni particolari, ogni elemento deve essere valutato con attenzione.
Per le situazioni più complesse – come fusioni, subentri, regimi agevolati, operazioni intracomunitarie, crediti IVA rilevanti – è fortemente consigliata l’assistenza di un commercialista, che può affiancare il contribuente nella gestione ottimale della dichiarazione e nell’adozione delle migliori strategie fiscali.
Un piccolo errore oggi può trasformarsi in un grande problema domani, ma una dichiarazione ben compilata può tradursi in risparmio fiscale, maggiore liquidità e una gestione fiscale più sana e trasparente.